 La Basilica di San Pietro
La Basilica di San Pietro in Vaticano è una basilica
cattolica che si trova a Roma, nella Città del Vaticano, all'interno
dello Stato Pontificio, a coronamento della monumentale Piazza San
Pietro.
L'immenso edificio è spesso descritto come la più grande chiesa
mai costruita e uno dei luoghi più sacri del cattolicesimo.
La costruzione di San Pietro fu iniziata sotto Papa Giulio
II, nel 1506, e si concluse nel 1612, regnante Papa Paolo V. Si
tratta in realtà di una ricostruzione, dato che nello stesso sito,
prima dell'attuale basilica, ne sorgeva un'altra risalente al IV
secolo, fatta costruire dall'imperatore Costantino nel luogo in
cui sorgeva il circo di Nerone e dove la tradizione vuole che San
Pietro, uno degli apostoli di Gesù Cristo e primo Papa del Cristianesimo,
fosse stato crocifisso e sepolto.
La basilica originaria era stata ripetutamente abbellita nel
corso dei secoli, anche con opere di Giotto, fin quando, a metà
del XV secolo, Nicolò V decise di avviarne una sostanziale ristrutturazione
dopo un furioso incendio che (casualmente o no) distrusse buona
parte della costruzione. Con la morte di quest'ultimo i lavori si
interruppero e vennero ripresi da Giulio II che ne affidò la direzione
al Bramante, il quale demolì gran parte della vecchia basilica,
progettandone una nuova a pianta centrale.
All'insieme delle opere necessarie per la sua realizzazione
edile ed artistica, fu preposto un ente, la Reverenda "Fabrica Sancti
Petri", del quale recentemente il Vaticano ha aperto gli archivi
agli studiosi: fra i preziosi documenti catalogati vi sono migliaia
di note, progetti, contratti, ricevute, corrispondenze (ad esempio
fra Michelangelo e la Curia), che costituiscono una documentazione
del tutto sui generis sulla quotidianità pratica degli artisti coinvolti.
L'ente è tuttora operante per la gestione del complesso.
La campagna per la raccolta di fondi per la costruzione della
basilica, effettuata in Germania con la vendita di indulgenze dal
frate domenicano Johann Tetzel, fu una delle cause della riforma
guidata da Martin Lutero.
La Basilica ha una lunghezza di 218 metri (187 metri la navata
interna), la cima della cupola è alta oltre 130 m e la superficie
totale supera i 15.000 metri quadrati. L’edificio può contenere,
si calcola, 8.000 persone. La basilica ospita quella che secondo
la tradizione cristiana e la recente ricerca archeologica è la tomba
di San Pietro, posta sotto l'altare principale, che è coperto da
un baldacchino sorretto da quattro immensi pilastri, tutti disegnati
dal Bernini. Il baldacchino fu costruito prelevando su ordine di
papa Urbano VIII il bronzo delle tegole e del rivestimento del pronao
del Pantheon. Anche altri Papi sono sepolti nella basilica.
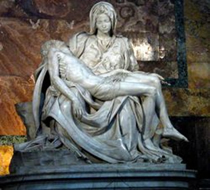
Con la morte di Giacomo della Porta, nel 1602, assunse la
direzione della fabbrica Carlo Maderno, nel 1603 il papa Clemente
VIII affidò la decorazione a mosaico della cupola al Cavalier d'Arpino,
in essa erano rappresentati: Cristo, gli apostoli e busti di papi
e santi, il tutto concluso entro il 1612, per la realizzazione delle
pale d'altare, riportate successivamente a mosaico, il papa si valse
di Pomarancio, Cesare Nebbia, Francesco Vanni, Bernardo Castello,
Giovanni Baglione, del Cigoli e del Passignano.
Sotto papa Paolo V, il Maderno iniziò nel 1607 la facciata
e nel 1609 la navata, entrambe concluse nel 1612, mentre tra il
1615 e il 1616, costruì la confessione a ferro di cavallo aperta
davanti l'altare maggiore. Per la decorazione scultore il papa si
servì maggiormente dell'opera di Ambrogio Bonvicino: suo è il rilievo
con La consegna delle chiavi posto sotto l'entrata principale, mentre
per la decorazione ad affresco si servì di Giovan Battista Ricci
di Novara, che lavorò agli affreschi della confessione e alla decorazione
in stucco. Tra il 1616 e il 1617, Martino Ferrabosco innalzò la
torre dell'orologio, abbattuta successivamente perché causava problemi
statici alla facciata.
Quando nel 1626 fu infine dedicata da Urbano VIII, la basilica
aveva la forma di una croce latina.
La basilica è in sé un'opera d'arte, ma è anche composta da
diversi elementi artistici di autonomo valore.
Molti famosi artisti lavorarono alla "Fabbrica di San Pietro".
Dopo la morte del Bramante iniziò a lavorarvi Raffaello Sanzio,
che modificò l'originaria pianta a croce greca in una a croce latina.
Michelangelo, che servì come capo architetto per un certo periodo
dopo Raffaello, riportò la pianta a croce greca ed eseguì il disegnò
della cupola. L'opera fu completata da Carlo Maderno, che tornò
di nuovo alla pianta a croce latina (stavolta su espresso ordine
del Papa).
All'interno trovano posto centinaia di statue in marmo, travertino,
stucco e bronzo. Tra i monumenti funebri ne troviamo uno del Bernini
e uno di Antonio Canova. Celebre è la scultura di Michelangelo "La
Pietà".
Artisticamente San Pietro rappresenta il trionfo del barocco
romano, in auge proprio nel momento in cui la Chiesa, stato politicamente
centrale nella storia europea, avvertiva il crescere del prestigio
e della potenza degli stati nazionali di Francia e Spagna. La sontuosità
architettonica e la ridondanza decorativa, già proprie dei canoni
del barocco, ben rispondevano all'esigenza della Curia di rappresentarsi
con una sperabilmente inarrivabile magnificenza.
La basilica venne finalmente consacrata nel 1626 da Urbano
VIII. La sistemazione della piazza (1656 - 67) è dovuta a Gian Lorenzo
Bernini (1598 - 1680), che realizza qui la sua opera più importante.
Lo spazio è suddiviso in due parti: la prima a forma di trapezio
rovescio con il lato maggiore lungo la facciata, la seconda di forma
ellittica con l'imponente colonnato dorico sormontato da una robusta
architrave. Nel progetto berniniano compariva uno spicchio centrale
("il nobile interrompimento") in prosecuzione del colonnato, che,
se realizzato, avrebbe nascosto la piazza e la basilica rispetto
alla veduta frontale. In questo modo, provenendo da Ponte Sant'Angelo,
il visitatore, dopo aver percorso le vie anguste del Borgo, si sarebbe
trovato all'improvviso in uno spazio vasto e solenne e avrebbe provato
di stupore e meraviglia. Va considerato a questo proposito che l'attuale
Via della Conciliazione è il risultato dell'opera di demolizione
(1936-1950) di un isolato lungo e stretto (la Spina di Borgo) tra
le strade oggi scomparse di Borgo Vecchio e Borgo Nuovo.
